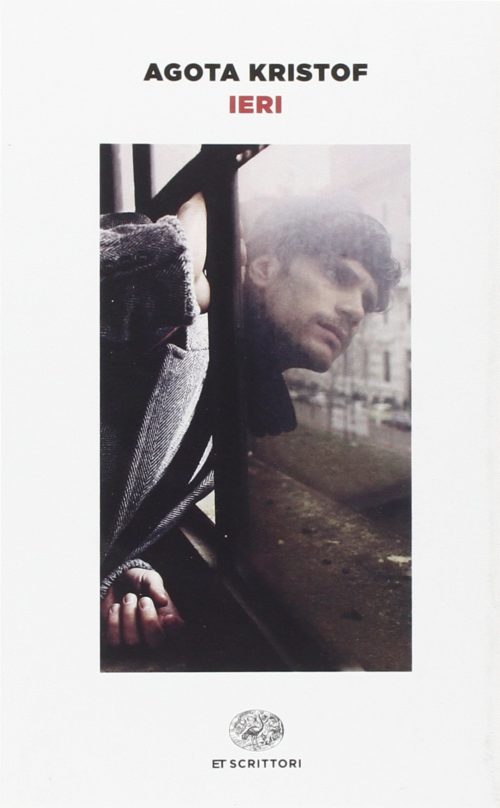The wind in my heart
The wind in my heart
The dust in my head
The dust in my head
The wind in my heart
The wind in my heart
(Come to) Drive them away
Drive them away.
Peter Gabriel, Listening Wind (Talking Heads Cover), 2010
Tutto in questo romanzo si muove sulle note del vento e della sabbia. La lettura è veloce come il colpo di un pugile sulla fronte, che penetra nella testa rilasciando un barile di sabbia nascosto nel guantone. Il testo è una musica dallo stile visionario ma incredibilmente realistico, tanto da poter essere definito pulp in alcune scene. È l’ultimo libro di una – purtroppo – misconosciuta autrice ungherese dalla vita tormentata, emigrata in Francia per via della guerra e scomparsa da poco: Agota Kristov (nota forse ad alcuni per il capolavoro La trilogia della città di K.).
L’autrice racconta la bieca storia di un uomo che lavora come operaio in una fabbrica di orologi. Non è un caso si tratti di una fabbrica di orologi (poteva trattarsi benissimo di un un’industria d’altro tipo): il tempo è un tema centrale della narrazione, che fa perno essenzialmente sull’attesa di Line, l’amata di Sandor, il protagonista. Line è la sua Beatrice, il suo ‘giovenile errore’, la sua spasmodica attesa, il suo incubo e il suo eden quotidiano. Una tigre di carta. Line è lui stesso. Line è la scrittura stessa: ‘Line, ti amo. Ti amo veramente, Line, ma non ho tempo per pensarci, ci sono tante cose alle quali devo pensare, per esempio questo vento, adesso dovrei uscire e camminare nel vento. Non insieme a te, Line, non ti arrabbiare. Camminare nel vento è una cosa che non si può fare altro che da soli, perché c’è una tigre e un pianoforte la cui musica uccide gli uccelli, e la paura può essere dissolta solo dal vento, si sa, io è tanto che lo so’.
Sandor scrive per necessità, in preda a un sortilegio oscuro. Una tigre entra nella sua casa e gli dice: ‘Musica! Suoni qualcosa. Al violino o al piano. Meglio al piano. Suoni!’… ‘Non sono capace, non ho mai suonato il piano in tutta la mia vita, non ho nemmeno un pianoforte, non l’ho mai avuto’ ribatte lui ‘In tutta la sua vita? Che sciocchezza! Vada alla finestra e suoni’. Sandor va alla finestra e vede un bosco: uccelli si riuniscono sui rami per ascoltare la sua musica. Come gli uccelli di Hitchcock. Le piccole teste inclinate e gli occhi fissi che guardano da qualche parte attraverso di lui. Un uccello morto cade da un ramo. La musica cessa. Lui si volta, la tigre sorride: ‘Per oggi basta… Dovrebbe esercitarsi più spesso’… ‘Sì, glielo prometto, mi eserciterò. Ma attendo visite, lei capisce, per favore. Essi, loro, potrebbero trovare strana la sua presenza qui, a casa mia’… ‘Naturalmente’ fa la tigre sbadigliando, e se ne va via a passi felpati.
Sandor nasce in ‘un villaggio senza nome, in una nazione senza importanza’. Sua madre, Esther, è la ladra, la mendicante, la puttana del villaggio. E lui, bambino, se ne sta nel cortile giocando con la terra argillosa: la plasma formando immensi falli, seni e natiche; scolpisce anche il corpo di sua madre, vi affonda le piccole dita per scavare dei buchi: la bocca, il naso, gli occhi, le orecchie, la vagina, l’ano, l’ombelico. Sua madre è ‘piena di buchi’, come la casa di Sandor, come i suoi vestiti, le sue scarpe: ‘tappavo i buchi delle scarpe col fango’.
La madre, oltre ai soliti contadini che in cambio del suo corpo ammazzano un maiale riservandole ‘le parti peggiori, le trippe e non so che altro’, inizia a portarsi a letto anche il maestro del villaggio: ‘quell’uomo, quello che mi carezzava i capelli, l’ho ritrovato a scuola’. Tale frequentazione segna la storia di Sandor, che ora ha vestiti e cibo buono e anche scarpe, quaderni, gomme, carta e matite. Il piccolo si rivela un alunno brillante e il maestro si prende cura di lui come se fosse suo figlio, assicurando che gli avrebbe fatto proseguire gli studi altrove per diventare medico, avvocato o ingegnere. Ma nel cuore di Sandor comincia a divampare odio per quell’uomo che pretende di essere suo padre e che gli chiede di abbandonare sua madre: ‘Non avevo che un desiderio: partire, andare, morire, era uguale. Volevo allontanarmi, non tornare più, scomparire, dissolvermi nel bosco, nelle nuvole, non ricordare più, dimenticare, dimenticare’. Così, prende dal cassetto ‘il coltello più grande, il coltello per tagliare la carne’, entra nella stanza dove i due consumano l’amplesso e affonda la lama nella schiena dell’uomo sotto il chiarore della luna piena. Da qui la fuga: Sandor scappa, passa il confine e, dopo una serie di peripezie, trova impiego nella fabbrica di orologi.
Ora comincia la sua ‘corsa idiota’: ‘Mi alzo alle cinque di mattina, mi lavo, mi faccio la barba, mi preparo un caffè e vado, corro fino alla piazza Principale, salgo sul bus, chiudo gli occhi, e tutto l’orrore della mia vita presente mi salta al collo’. Il lavoro dà pochi spiccioli e non è particolarmente divertente. Sandor vede ancora tanti buchi, ma nessun orologio con le lancette che vanno in senso orario: ‘La fabbrica produce pezzi di ricambio e pezzi semilavorati per altri stabilimenti. Nessuno tra noi potrebbe assemblare un orologio completo. Quanto a me, con il mio macchinario faccio un buco nello stesso pezzo da dieci anni’. Il tempo sembra essersi fermato; sembra non esistere. È una scelta narrativa dell’autrice: la vita scorre come un nastro pieno di buchi, senza passato e senza futuro. E il presente si può riassumere nel vuoto, in un singolo buco. Tornato nel suo buco (un mini appartamento sciatto e sporco che pare vivere di vita propria), Sandor scrive, sempre a matita, su fogli che spesso distrugge. E aspetta: Line può arrivare da un momento all’altro.
A un certo punto Line compare: sale, al primo villaggio, sullo stesso bus di Sandor. O meglio, entra in scena una donna che a Sandor ricorda una compagna di banco della sua infanzia. Ad ogni modo, quella donna diventa Line in carne ed ossa. Si è trasferita con il marito, un biologo, che ha avuto un incarico a tempo indeterminato in quella località. Lui la insegue in bicicletta e la scruta con il binocolo attraverso la finestra della sua casa borghese e felice: ha una bambina. Il fuoco della gelosia divampa in Sandor che si avvicina sempre di più a Line. I due finiscono per diventare amanti; e basta un abbraccio, un bacio in un viottolo zeppo di neve perché lui abbia il fiotto rovente di un’eiaculazione. Lei ripulisce il suo buco, si prende cura di tutto ciò che lui trascurava; e Sandor sogna, non riesce a credere che il suo personaggio inventato, sia nelle sue mani, che tutte le parole scritte a matita sotto l’incalzante monito della tigre siano finalmente tra le sue braccia.
Tuttavia, la scrittura non si può dominare del tutto, non si può sposare: la scrittura non è un trastullo borghese, ma un vento ribelle infestato di uccelli feriti nel quale si può camminare unicamente da soli. Sandor non può diventare marito. Questo sembra dirci l’autrice: ‘bisogna diventare assolutamente niente per essere scrittore’. Lo scrittore rischia perennemente un cortocircuito (e Sandor ne rimane vittima). Scrivere è un atto solitario; è un atto di rinuncia. È un atto che sorvola la realtà, che non si lega alla realtà, anche se nella realtà trova la sua origine. Line, infatti, decide di andarsene con il marito, che ha portato a termine il suo incarico: ha una bambina, lei non può vivere in un buco, lei non può stare con lui anche se lo ama per ovvie ragioni.
Sandor parla con un uccello ferito, che gli dice: ‘Io conosco campi meravigliosi. Se tu potessi raggiungerli, ignoreresti il tuo cuore. Là non ci sono fiori, l’erba ondeggia come una bandiera, quei campi felici sono senza limite. Non avresti che da dire: terra di pace, vorrei riposarmi’… ‘Sì lo so’ ribatte lui ‘ma passerà un’ombra, un dipinto, una poesia, un’aria’… ‘Allora vai sulla montagna’ dice l’uccello ‘e lasciami morire. Non posso sopportare la tua tristezza. Tristezza dei gesti, delle cascate color cenere, tristezza dell’alba che si muove lungo i campi fangosi’. Sandor, partita Line, si sposa con una bionda qualunque e sforna due figli: ‘La mattina li lasciamo all’asilo nido. Li riprendiamo la sera. Mia moglie, Yolande, è una madre esemplare. Lavoro sempre alla fabbrica di orologi. Al primo villaggio nessuno sale sul bus. Non scrivo più’.
Il libro di Agota Kristov è un piccolo capolavoro poetico. Una metascrittura in versi in cui la scrittura non si rivela uno strumento per comunicare, ma un impulso drammaticamente organico, seminvolontario e autodistruttivo, volto a disperdere il sé per dimenticare la paura di esistere, per trovare una vaga forma tangibile dei propri desideri impossibili nel ritmo del pianoforte e della tigre, nella musica del vento.
L’Inesistente