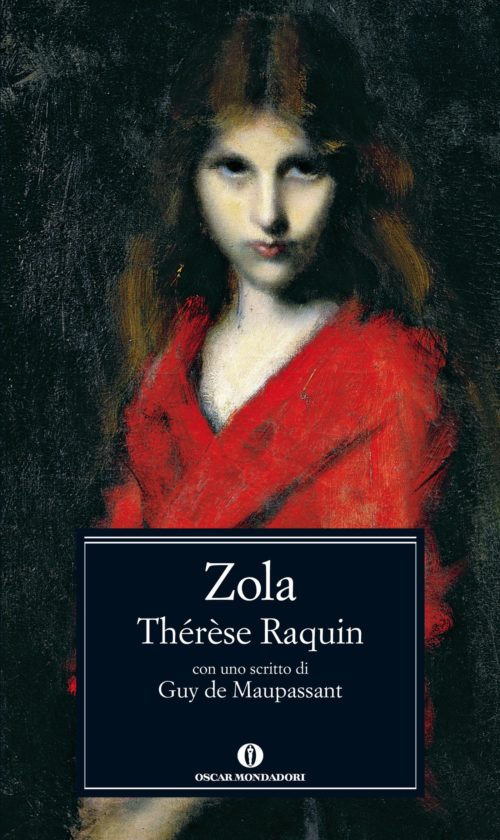I can’t seem to face up to
the facts
the facts
I’m tense and nervous and I
Can’t relax
I can’t sleep ‘cause my bed’s on fire
Don’t touch me I’m a real live wire
Psycho Killer
Qu’est-ce que c’est
fa fa fa fa fa fa fa fa fa far better
Run run run run run run run away.
Can’t relax
I can’t sleep ‘cause my bed’s on fire
Don’t touch me I’m a real live wire
Psycho Killer
Qu’est-ce que c’est
fa fa fa fa fa fa fa fa fa far better
Run run run run run run run away.
Talking Heads, Psycho Killer, 1977
Uccidere una sola volta è rischioso: la vittima potrebbe non essere morta abbastanza; potrebbe ricomparire in varie forme, affacciarsi all’oblò dell’immaginazione, intrufolarsi nelle nostre lenzuola e nel nostro sangue. Uccidendo qualcuno o qualcosa (sì, anche un’idea può essere uccisa), non produciamo necessariamente l’assenza di ciò che eliminiamo bensì, nella maggioranza dei casi, una presenza alternativa di ciò che volevamo eliminare. Una persona affogata in un fiume, per dirne una, anche se ha smesso di respirare ed è ridotta a una poltiglia di tessuti marci, non è detto che abbia smesso di esistere; anzi, il suo respiro si rigenera nell’aria respirata da chi ha commesso il delitto; la sua sagoma si moltiplica disperatamente là dove le pupille degli assassini cercano pace.
L’estetica di Zola è all’insegna di un contrasto cromatico macabramente irrequieto. La narrazione procede rovente, dominata dal rosso della passione che manifesta la sua fisiologia nei due amanti assassini – Thérèse e Laurent – come attrazione/repulsione nevrotica, e dal giallo della luce malsana emanata dall’argilloso corpo di Camille – lo sposo annegato – e dall’atmosfera abietta della bottega gestita da Mme Raquin; tuttavia, le scene sono intrise di colori freddi, con una dominanza di blu e di verde, che fanno trasudare da ogni singola pagina un’umidità irrimediabilmente folle.
Il contrasto cromatico permea il romanzo dalla prima all’ultima riga, generando un testo compatto, un dipinto le cui pennellate, amalgamandosi, danno luogo a un’unica immagine delirante, perfettamente credibile e piacevolmente orrida. Attraverso questa scelta stilistica, nel suo capolavoro d’esordio l’autore francese alterna naturalismo e manierismo.
Il naturalismo si esprime nella descrizione oggettiva del modo in cui le esperienze psicofisiche dei protagonisti si evolvono. Thérèse e Laurent vengono prima travolti dalla concupiscenza – che li porta a perdersi voluttuosamente nell’adulterio, e poi a commettere un omicidio nell’intento di poter finalmente sfogare i propri sentimenti nell’illusoria libertà del riconoscimento borghese della loro unione con un secondo matrimonio – poi vengono travolti dall’incubo – determinato dalla constatazione che, non appena ottenuta l’unione tanto bramata, il desiderio si è estinto lasciando spazio a una schiavitù di paure tragicamente insolubili, perché Camille non si è affatto dissolto nella Senna, ma si materializza perseguitandoli ovunque, rendendo ripugnante ogni loro possibile amplesso, fino a condurli a un invincibile bisogno di ammazzarsi a vicenda. Ultimo atto: acqua zuccherata + HCN, dallo stesso bicchiere.
Il manierismo è stato definito da John Sherman uno Stylish Style: linguaggio artificioso, colto e virtuosistico ma attento a esibire, celando con disinvoltura le difficoltà dell’arte. Prendendo spunto da questa definizione, è difficile non notare una certa analogia con gli espedienti estetici messi a punto da Zola in Thérèse Raquin. Ad esempio, il morso di Camille sul collo di Laurent, non è soltanto il marchio impresso dall’annegato sulla pelle del carnefice. Il morso di Camille è un simbolo che amplifica simboli, i simboli di una nevrosi condivisa e maledettamente assaporata. Quel morso è il fulcro dell’ubiquità di un’ossessione post-delitto che non cessa di tormentare i due amanti. Il cadavere di Camille – forse osservato troppo a lungo alla Morgue nei dettagli più raccapriccianti del suo decomporsi – stilla putrefazione nella loro intimità più profonda: ‘Si strinsero in un abbraccio orribile. Ai desideri subentrarono il dolore e lo spavento. Al contatto delle membra ebbero l’impressione di essere precipitati su un braciere. Cacciarono un grido e si avvinghiarono ancor di più, per non lasciare spazio all’annegato. E sentivano sempre interporsi i brandelli di Camille che raggelavano qua e là la loro pelle, mentre il resto dei corpi ardeva. I baci furono orribilmente crudeli. Thérèse cercò con le labbra la morsicatura di Camille sul collo gonfio e rigido di Laurent e incollò la bocca con trasporto sulla piaga viva’.
Un’altra suggestione, relativa al manierismo di Zola, si lega alla figura di Pontormo, così descritto da Vasari nell’edizione giuntina delle Vite (1568): ‘Non avendo fermezza nel cervello andava sempre nuove cose ghiribizzando […]. Andava sempre investigando nuovi concetti e modi di fare, non si contentando e non si fermando in alcuno […]. La bizzarra stravaganza di quel cervello di niuna cosa si accontentava giammai’. Il giudizio (negativo) vasariano si spiega alla luce di una frattura generazionale che andava allargandosi nella vicenda artistica dei decenni centrali del XVI secolo. Pontormo era un pittore eccessivo per i gusti di Vasari; misantropo, sciatto, lunatico; diciamo anche un po’ fuori di testa; in particolare, ossessionato da se stesso (o dall’idea di se stesso). I volti che disegnava si assomigliavano quasi tutti. Basta guardare quelli del Trasporto di Cristo conservato nella Cappella Capponi nella chiesa di Santa Felicita a Firenze (1526-1528). Volti che fluttuano in splendidi contrasti cromatici. C’è perfino il suo autoritratto (la faccia barbuta sulla destra).
Laurent, nella fase post-delitto, affitta una mansarda e si dedica con solipsistica ferocia alla pittura, sua vecchia amatoriale vocazione. Un amico di passaggio rileva un miglioramento incredibile nel suo tratto, una metamorfosi artistica eccezionale, ma… I volti si assomigliano tutti… Assomigliano a Camille: ‘Il primo rappresentava la faccia di un vecchio, con una lunga barba bianca; sotto la barba, si indovinava il mento sottile di Camille. Il secondo era una ragazza bionda, e la ragazza lo stava guardando con gli occhi azzurri della vittima. Anche gli altri tre ritratti avevano alcuni lineamenti dell’annegato […]. Ognuna aveva una leggera piega alla sinistra della bocca, che increspava le labbra e le faceva sogghignare. L’ignobile parentela che le marchiava era la stessa che Laurent si ricordò di aver visto sulla faccia convulsa dell’annegato’.
L’esistenza non ha un rapporto diretto con la vita. La non-vita può esistere, così come la non-esistenza può vivere. E ci si può ritrovare accanto la faccia ghignante di noi stessi, dell’idea di noi stessi, di altri o di altro che abbiamo invano cercato di uccidere.
Zola analizza questo cortocircuito con l’occhio del naturalista e del manierista. Thérèse Raquin è un romanzo sulla fisiopatologia dell’incubo e del suo stretto legame con l’arte, intesa come corso d’acqua in cui zampillano le nostre ossessioni, che sfocia nella vita e nella non-vita.
L’Inesistente